Elogio dell’imperfezione

Ciro Paone riceve il premio Pitti Immagine
Lo scrittore Raffaele La Capria, napoletano verace, così racconta di uno zio: “C’era a Napoli, quando io ero ragazzo, un mio zio che non aveva lavoro e quando qualcuno glielo rinfacciava lui rispondeva: Io vesto. Come se vestirsi bene fosse non dico un lavoro ma qualcosa di utile alla società”.
Non ha tutti i torti La Capria alludendo al bel vestire come ad un modo d’essere, che richiama lentezze e raffinatezze d’altri tempi, quando Curzio Malaparte o Vittorio De Sica commissionavano al mitico Gennaro Rubinacci un abito in tweed o uno smoking, sottoponendosi a lunghissime sedute di prova in quello che era un camerino-confessionale.
Ancora oggi la sartoria partenopea è sinonimo di eleganza in tutto il mondo, avendo tra i principali estimatori grandi manager e capitani d’industria, uomini di Stato e attori famosi.

Abiti Kiton
Il segreto sta nell’aver coniugato i pregiati tessuti d’Oltremanica alla manifattura locale, riuscendo ad ammorbidire lo stile dell’abito inglese (senza disdegnare le nuove tecnologie, ma restando ossequiosi della tradizione).
Tutto ebbe inizio a fine Ottocento con Filippo De Nicola, capostipite di una grande dinastia sartoriale, che spedì il figlio Adolfo a far pratica a Londra. E questi non lo deluse, visto che diventò sarto di Sua Altezza Reale. Comunque, a ricreare l’abito contemporaneo fu la coppia d’oro costituita da Gennaro Rubinacci e Vincenzo Attolini, l’uno più “stilista”, l’altro più “sarto”, ovvero maestro di taglio e cucito.
A loro si deve la classica giacca napoletana, con la cosiddetta “manica a camicia”, i quattro bottoni delle asole, il “tre bottoni strappato a due”, lo scollo a “martiello” e il taschino a “barchetta”. Il risultato è un capo “unico”, meno perfetto, ma più leggero e vestibile di quello inglese (un po’ troppo rigido), perché cade addosso come una seconda pelle, che ci si dimentica di portare. Attolini sentenziava: “A giacca addà zumpà arreto”, deve saltare dietro. E quelli che ai profani sembrano difetti, sono in realtà i segni di una fattura e di una qualità artistica distintive. Come in quadro impressionista, la cura dei singoli dettagli si amalgama alla fine nella visione di un intero armonico e preciso.

cappotti Attolini
Guerra e dopoguerra, però, eclissarono non poco i fasti della moda napoletana, che si vide insidiata soprattutto dal trionfo della confezione e della moda pronta.
Fu grazie all’intuizione imprenditoriale di un uomo come Ciro Paone (fondatore di Kiton), cui poi seguirono altri personaggi di talento, che fecero conoscere ed apprezzare l’abito napoletano in America e in Giappone, se la sartoria della città riuscì a decollare un’altra volta, vincendo oltre alla sfida della produzione (comunque non in termini quantitativi, per scelta) anche quella della distribuzione e della comunicazione.
Così, se oggi i grandi della terra vogliono vestire “alla napoletana”, senza badare al prezzo, non possiamo che fare un “elogio dell’imperfezione”, togliendoci il cappello di fronte ad una leggenda italiana che continua.

Giacca Rubinacci
Alla luce di tutto ciò, siamo curiosi di sapere come la sartoria napoletana (compresa quella industriale), ispirata ai valori dello slow-fashion, interpreterà i nuovi trend produttivi secondo cui le case di moda dovranno essere sempre più veloci, sfornando modelli diversi a distanza ravvicinata, con flessibilità e precisione.
A detta dei fashion guru, infatti, la “moda veloce” è l’unica ricetta per sopravvivere alla tempesta della crisi: è il rinnovamento ad attrarre i clienti, ovvero l’alta rotazione dei prodotti a prezzi invitanti e qualità garantita, in grado perfino di azzerare i sensi di colpa degli “affluent” verso chi ha meno disponibilità. In effetti, molti esponenti del Gotha dell’abbigliamento italiano hanno già cominciato a reinventarsi in chiave fast, calamitati da un business che si annuncia miliardario.
Come attraverserà questo guado la tradizione partenopea? Con la sua classica eleganza, si spera.





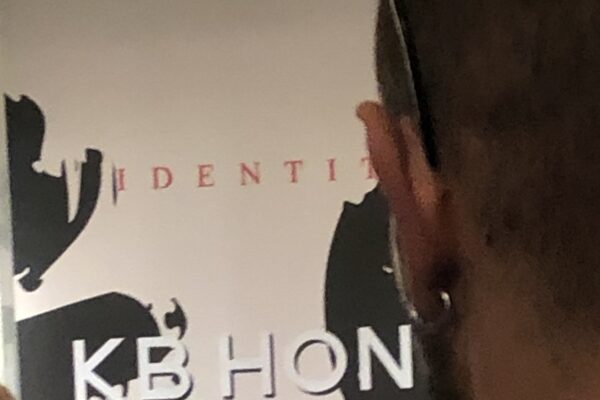





 Visita il canale You Tube di IMORE
Visita il canale You Tube di IMORE



