Dinastie erranti
I Buddenbroock – la famiglia del celebre romanzo di Thomas Mann – sono usciti dalla sfera letteraria ed hanno prestato il loro nome ad un tipo di “sindrome” che molti imprenditori titolari di aziende familiari aborriscono: secondo questa teoria, la prima generazione crea, la seconda consolida e la terza distrugge. In effetti, la successione in queste aziende, ovvero il “passaggio di testimone” da una generazione ad un’altra, rappresenta uno dei momenti più decisivi del loro ciclo di vita. Circa il 90% delle imprese italiane è a gestione familiare e tale fenomeno tocca largamente anche il settore della moda. Come si affronta, allora, il passaggio generazionale?
Nella gestione della continuità d’impresa i pericoli più seri derivano dalla personalizzazione spinta dei ruoli di potere, dalla complessità del rapporto tra imprenditore e manager, dagli eccessi di finanziarizzazione. Quando la leva finanziaria è il driver, possono nascere differenti visioni e valori tra chi pensa alla produzione di ricchezza sul breve termine e chi ragiona in termini di capitale e di patrimonio. Quello che resta fondamentale è una sana gestione dei valori, che passa attraverso la scelta di uomini competenti, capaci e curiosi, che operino con passione ed entusiasmo, senza essere patiti della regola del “tutto e subito”.
Gli imprenditori italiani in generale non sembrano ancora ben consapevoli che la successione sia un processo lungo, che deve essere programmato nel tempo. Spesso, invece, si rischia di intervenire in corsa, per cui possiamo dire senz’altro che nel nostro Paese è diffusa una mera “cultura dell’ereditare” che non favorisce l’assunzione di responsabilità.
Per quanto concerne poi le problematiche critiche – economiche, psicologiche, culturali – la dimensione più rilevante è quella mentale. Infatti, per chi deve succedere, il problema è l’incertezza di dover ripartire. Se si subentra a persone straordinarie, la domanda che ci si pone è come replicare e portare avanti quella straordinarietà, che spesso è patrimonio di un solo cervello. Il punto più delicato diventa, quindi, l’individuo, la sua storia, i suoi successi e fallimenti, la sua formazione scolastica e personale. Per lo sviluppo di nuova imprenditorialità nelle giovani generazioni è sempre più essenziale il ruolo che possono esercitare i media e le istituzioni educative, oltre alle famiglie (nelle quali, secondo alcuni, “ci vogliono più padri che madri”, quindi più autorevolezza che protezione). Si deve, soprattutto, rafforzare di molto la propensione dei giovani al rischio, coltivandola e mettendola in correlazione con alcuni “paracadute”, sempre essenziali. Comunque, vi possono essere tre tipi di “deriva” dei giovani eredi: la deriva padronale (“l’impresa è mia e la gestisco io”), la deriva del disinteresse (“possedere un’impresa equivale a possedere un immobile come un altro”), la deriva finanziaria (“l’impresa vale solo per quello che rende”): esiste una differenza basilare tra chi si immagina imprenditore e chi si immagina solo proprietario. In sostanza, per favorire il ricambio delle classi dirigenti, occorre creare delle reti che vedano protagoniste insieme scuole, università, associazioni, iniziative di formazione che promuovano il coaching.
In definitiva, risulta fondamentale per l’azienda acquisire dei validi manager, eventualmente anche dei “provocatori” o dei “rompi-scatole”, che abbiano però passione, con i quali instaurare un confronto fondato su toni costruttivi e, se talvolta necessario, pure vivaci (attenzione, comunque: i manager non sempre garantiscono risultati mirabolanti e possono rivelarsi un’arma a doppio taglio, se fra loro e la proprietà non si stabilisce un equilibrio, soprattutto in fatto di scelte di investimento: i manager tendono a spendere, gli imprenditori a risparmiare). Va aggiunto altresì che anche un buon dirigente può diventare un buon successore ed un buon imprenditore: il management buyout, infatti, può effettivamente essere uno strumento ed un’alternativa positiva, magari meramente transitoria.
Veniamo, poi, al “pater familias” che si trova a programmare la sua uscita di scena. Per lui è necessario trovare un nuovo ruolo, che può essere quello di saggio consigliere (la soluzione, però, va trovata prima che egli sia troppo vecchio, altrimenti finisce che resta in azienda sino alla fine, rendendo la sua presenza molto difficile).
In conclusione, come ha efficacemente schematizzato il noto consulente aziendale Gianfilippo Cuneo, i dieci “errori tipici” delle dinastie imprenditoriali sono:
1) credere che il figlio sia capace di gestire l’azienda;
2) confondere il ruolo dell’azionista con quello di manager;
3) insistere per mantenere il controllo dell’azienda;
4) rinviare il momento in cui si apre a terzi il capitale dell’azienda;
5) incapacità di scegliere manager validi;
6) incapacità nello strutturare un rapporto fra proprietà e management orientato alla creazione di valore;
7) incapacità di accorgersi che i fattori di successo del passato sono inesorabilmente cambiati e possono persino trasformarsi in boomerang;
8) aumentare l’indebitamente oltre misura;
9) diversificazione: pericolo o opportunità;
10) pensare di essere più “furbi” degli altri.
Tali sbagli possono essere classificati anche in un’altra maniera, raggruppati in tre categorie:
– quelli legati alla “visceralità” dell’imprenditore, che considera l’azienda come un pezzo della famiglia e non riesce a capire che potrebbe essere meglio, anziché controllare al 100% la sua “creatura” facendola gestire da un figlio non all’altezza, farla crescere con soci finanziari o industriali;
– quelli tecnici, evitabili grazie ad un buon consulente esterno che sappia analizzare i cambiamenti del contesto competitivo;
– quelli legati all’indebitamento, sovente connessi ad investimenti fuori dal proprio business, senza avere l’umiltà di riconoscere che il successo e le competenze acquisiti in origine non servono più.
Errare industriale est, perseverare…

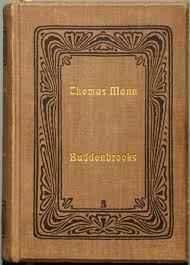




 Visita il canale You Tube di IMORE
Visita il canale You Tube di IMORE



