IL Rond² delle vanit
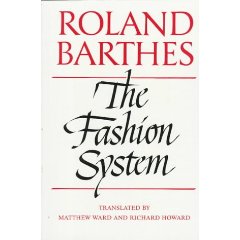 Quella costellazione di talento, business, cultura e vanità che va sotto il nome di moda italiana, che per alcuni assomiglia sempre più alla Norma Desmond di “Sunset Boulevard” e ad altri sembra ancora un’appetibile Lolita, quale parte della sua orbita ha descritto e dove sta andando?
Quella costellazione di talento, business, cultura e vanità che va sotto il nome di moda italiana, che per alcuni assomiglia sempre più alla Norma Desmond di “Sunset Boulevard” e ad altri sembra ancora un’appetibile Lolita, quale parte della sua orbita ha descritto e dove sta andando?
Non c’è bisogno di scomodare la famosa tela di Gaugin (“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”) per porsi questi interrogativi, anche se forse è proprio dall’arte che può decollare la nostra analisi.
 La moda italiana, infatti, non è altro che la prosecuzione delle tradizioni artistiche e culturali del nostro Paese, ovvero il recupero delle doti espressive della nostra storia.
La moda italiana, infatti, non è altro che la prosecuzione delle tradizioni artistiche e culturali del nostro Paese, ovvero il recupero delle doti espressive della nostra storia.
Come ha affermato il filosofo e critico d’arte Gillo Dorfles qualche anno fa, “se le Grandi Arti sono in declino, occorre riconoscere che il design, appunto la moda, ha saputo rimpiazzarne la preminenza con tutta l’originalità possibile e immaginabile”.
Posto che i nostri bravi stilisti avranno sempre qualcosa da dire, mantenendo una posizione di punta a livello internazionale, va pur riconosciuto che sono in corso mutazioni genetiche del fashion system, sotto il profilo concettuale innanzitutto. Così, se prima era un must imporre una determinata tendenza a livello sia materiale che spirituale, per così dire, da qualche tempo vige l’indifferente accettazione di tutto. Dunque, se va la minigonna va anche la longuette, se va il nero va anche il bianco, se va il casual va anche l’alta moda, e così via. In altri termini, è vero che la couture ad ogni stagione continua ad emettere i suoi effimeri e transitori diktat, ma è altresì vero che ora si può seguirli senza patemi, scegliendo ciascuno come differenziarsi con originalità, spaziando fra marchi, epoche, stili. Per usare un gioco di parole, si potrebbe affermare che vestirsi alla moda non è più di moda.

Ted Polhemus
E visto che siamo diventati surfisti dell’abbigliamento, l’antropologo Ted Polhemus ha decretato che “non ci sono più quelle che una volta si chiamavano le vittime della moda”, aggiungendo lo slogan: “Stilisti, voi forniteci gli aggettivi e i sostantivi. La frase la costruiamo noi”.
In questo contesto, anche il valore del brand sta forse cambiando, sull’onda di quanti, sempre più numerosi, restano persuasi della necessità di autorappresentarsi al di là di ogni omologazione e serialità, refrattari a rimpiazzare il prodotto con una griffe, convinti che l’autentica funzione della firma – di per sé priva di vita propria – debba essere il conferimento di valore ad un unicum effettivo (a proposito, sapete che fu Charles Frédérick Worth, sarto inglese dell’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone, il primo a scrivere il proprio nome sugli abiti disegnati, per sottolineare così di essere un artista?).
Finalmente qualcuno osa fare outing contro il pret-à-porter, colpevole di aver sistematizzato l’estetica, dagli anni ’60 in poi, fino ad ottundere e ridurre in fin di vita quel desiderio che è l’essenza stessa della moda, convertendo il capriccio di una stagione in un tam-tam martellante. Evitiamo le divise, please, anche se nobilitate da materiali qualitativamente ricercati o virtuosamente sperimentali.

C. Frédérick Worth abito per Elisabetta d'Austria ritratta da F.X.Winterhalter
Il mondo sembra patire un eccesso semiologico, dove i segni sono abiti, accessori, oggetti per troppo tempo concepiti con irrazionale euforia. Vedi la femminilizzazione del maschio prima e la sua neutralizzazione poi, la corsa a stili fintamente innovativi, l’uniformità estetica, l’erotizzazione di ogni proposta, il sibarismo comportamentale.
Sembra ora giunto il momento di fermarsi per ridefinire le regole, condicio sine qua non per essere poi legittimati a trasgredirle di nuovo. E intanto si punta sulla scenografia, sulla coreografia della rappresentazione, tanto per comunicare qualcosa, sforzandosi di recuperare una visione bifocale delle questioni e riscoprire lo spessore delle cose.
Infine, per quanto concerne il non sempre facile rapporto tra la moda e le istituzioni, mi si lasci dire che le nostre capitali della moda, Milano in primis, più e meglio dovrebbero metabolizzare strategicamente la figura dello stilista rimarcando l’attualità e l’importanza dei valori culturali e creativi che sottendono il suo lavoro. Insomma, dovrebbero guardare un po’ oltre la teatralità performativa della passerella, inquadrandola come un fenomeno di cultura sostanziale, non estraneo ad altre forme di arte.
Cosa che nemmeno il mezzo televisivo, per quanto potente, è mai sembrato in grado di compiere. Il suo linguaggio, in effetti, stride drammaticamente col discorso della qualità sartoriale ed è una pia illusione, se non un boomerang, credere che per “fare comunicazione” dagli alti ritorni commerciali basti saturare il video di modelle mozzafiato pericolosamente oscillanti su scalinate storiche. Il critico televisivo Aldo Grasso ha definito questa “una moda irrelata che parla a se stessa”, denunciando per giunta il paradosso secondo cui “il meglio della televisione odierna irride la moda corrente: il vestito slabbrato da cronista anni Cinquanta di Piero Chiambretti, le giacche bulgare di Gene Gnocchi, il chiodo di Corrado Guzzanti sono, per definizione, inimitabili e contro tendenza. Chi insegue l’idea dell’abito buono, dell’abito della festa, come fanno Gigi Marzullo o Aldo Biscardi, si predispone subito alla caricatura”.
Il messaggio mi sembra chiaro: è opportuno riposizionare l’attenzione dal risultato – l’abito – all’ideazione – il progetto sartoriale – concentrandosi sulla corrispondenza esistente fra se stessi e la rappresentazione di sé, sul gioco senza fine tra il proprio essere e lo spazio che si occupa nel mondo visivo ed emotivo.


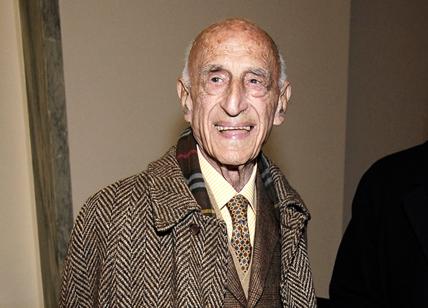



 Visita il canale You Tube di IMORE
Visita il canale You Tube di IMORE



