Una passerella lunga come il mondo
“La moda è la parte d’Italia che guarda già oltre” ha dichiarato Simona Segre Reinach, antropologa della moda, che ha appena dato alle stampe per Laterza “Un mondo di mode. Il vestire globalizzato”. Da un’esperta come lei viene la conferma, in effetti, che qualcosa sta cambiando in passerella, dove sempre più si coglie un intreccio tra moda e aristocrazia che scaturisce – per usare le sue parole – dal “desiderio d’aristocrazia d’animo”, quasi ci si volesse liberare dalla volgarità, dal malcostume, da un’immagine femminile avvilente. Non a caso, molte icone di stile contemporanee provengono da prestigiose case reali o comunque dell’alta nobiltà, come Rania di Giordania, Charlotte Casiraghi, le sorelle Borromeo, Bianca Brandolini d’Adda.
Oggi sembra che la nostra moda stia meditando sul proprio passato per recuperarne i principi fondanti, valorizzare il proprio patrimonio storico, ritrovare le radici di un sapere unico, distintivo. Di qui la crescente selettività dei riferimenti, per cui la moda si fa sempre più elitaria nei suoi modelli e codici, rivelandosi dunque un’autentica moneta di scambio culturale mentre ci indica la direzione in cui sta procedendo il mondo.
Nel suo libro, la Segre Reinach affronta il cruciale tema dell’economia generata dalle passerelle – catwalk economy – finora sottovalutata dagli Italiani, che non hanno compreso pienamente quanto il fashion system, lungi dall’essere uno scrigno di frivolezza, possa offrire in termini di estetica e civiltà ai luoghi in cui si sviluppa. Lo stanno capendo bene, invece, Paesi come il Brasile, il Senegal, l’India,la Cina, i cui cittadini vedono nella moda un volano di modernità: “Le moderne capitali della moda – ha osservato l’antropologa – sono luoghi vivaci che attraverso questo linguaggio esprimono la loro partecipazione alla contemporaneità”.
Una “rivoluzione” per la moda è stato proprio il fenomeno della globalizzazione, che ha dilatato a dismisura e a tempo record la fucina creativa, favorendo rapporti di nuovo genere tra luoghi e persone impensati sino a pochi anni fa. Le ultime ricerche antropologiche si muovono tutte, quindi, verso lo studio delle diverse mode locali, da un lato, e della diffusione globale dei brand occidentali, dall’altro. Si potrebbe dire che non è in atto una mera “emancipazione da Parigi”, ma si sta configurando un nuovo fashion system su scala planetaria non più baricentrico e in progressivo sbilanciamento verso l’Asia, come denotano gli attuali equilibri in assestamento tra immagini, prodotti, percorsi creativi, modi di consumo, visioni.
La stessa Segre Reinach scriveva già nel 2007: “Sempre più l’Asia è il luogo a cui si guarda per individuare il “nuovo”. La moda, come spesso accade, ne costituisce un punto di vista privilegiato. Il caso Italia e Cina, in particolare, nella competizione tessile-moda degli ultimi anni, offre molti spunti di riflessione su questo ribaltamento dei ruoli. La relazione sartoriale tra i due Paesi riproduce vecchi stereotipi orientalisti e al tempo apre nuove prospettive, sia nel campo dello stile, sia in quello dell’industria”. Per certi aspetti, infatti, noi Occidentali conserviamo una sorta di mentalità coloniale, idealizzante e retorica, arrivando a “brandizzare” l’esotico per renderlo etno-chic o glam-chic (si vedano le giacche alla Mao o le camicie alla Nehru addosso alle modelle che sfilano). E’ dura a morire la convinzione per cui noi siamo creativi e al massimo ci ispiriamo ad Oriente, mentre gli “altri” sono bravi solo a copiare e non si sforzano di innovare. Su un altro fronte, resta forte lo specifico rapporto tessile fra Italia e Cina, che ormai va ben oltre il business della seta. La capacità dei Cinesi di uscire dal circolo vizioso della copia e di agire direttamente sullo stile e sulla produzione, risale all’incirca agli anni ’80, come pure documentano i bei film “Mao’s new suit” (diretto da Sally Ingleton, 1999) e “Shanghai Dreams” (del regista Wang Xiaoshuai, 2005).
La globalizzazione ha accelerato tutti i processi in ambito tanto culturale quanto economico. La scelta strategica di parecchie aziende italiane di delocalizzare alcune fasi produttive in Oriente per beneficiare di un minore costo del lavoro ha comportato un ripensamento dello stesso concetto di “made in Italy”. A fronte del fenomeno, l’antropologa Segre Reinach si era espressa così già qualche anno fa: “Il vero made in Italy, se si vuole farlo coincidere con il prêt-à-porter, è ormai fatto in Cina, nella maggior parte dei casi e in modo più o meno mascherato, occultato, a seconda delle strategie delle aziende. Il falso made in Italy (cioè il pronto, falso per chi identifica il made in Italy con l’idea della filiera integrata, dello stilista, dell’irriproducibilità dei distretti e altre amenità su cui si organizzano ancora molti convegni sulla moda) è fatto in Italia da Italiani in collaborazione con Cinesi che hanno aziende in Italia”.
Va da sé che per la moda italiana si tratta ora di rielaborare in chiave globale il concetto di made in Italy emancipandolo prima di tutto dall’identificazione con le logiche del prêt-à-porter anni ’80. Alla Segre Reinach il compito di concludere: “E’ il riconoscimento, ancora una volta, dell’inautenticità della moda, ovvero della sua vera natura culturale, abbandonata ogni idea di falsa naturalezza, fosse anche quella del prodotto bello e ben fatto che esce dalla bottega rinascimentale”. Parole che ci lasciano molto, ma molto pensosi.

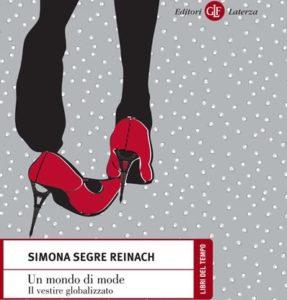




 Visita il canale You Tube di IMORE
Visita il canale You Tube di IMORE



